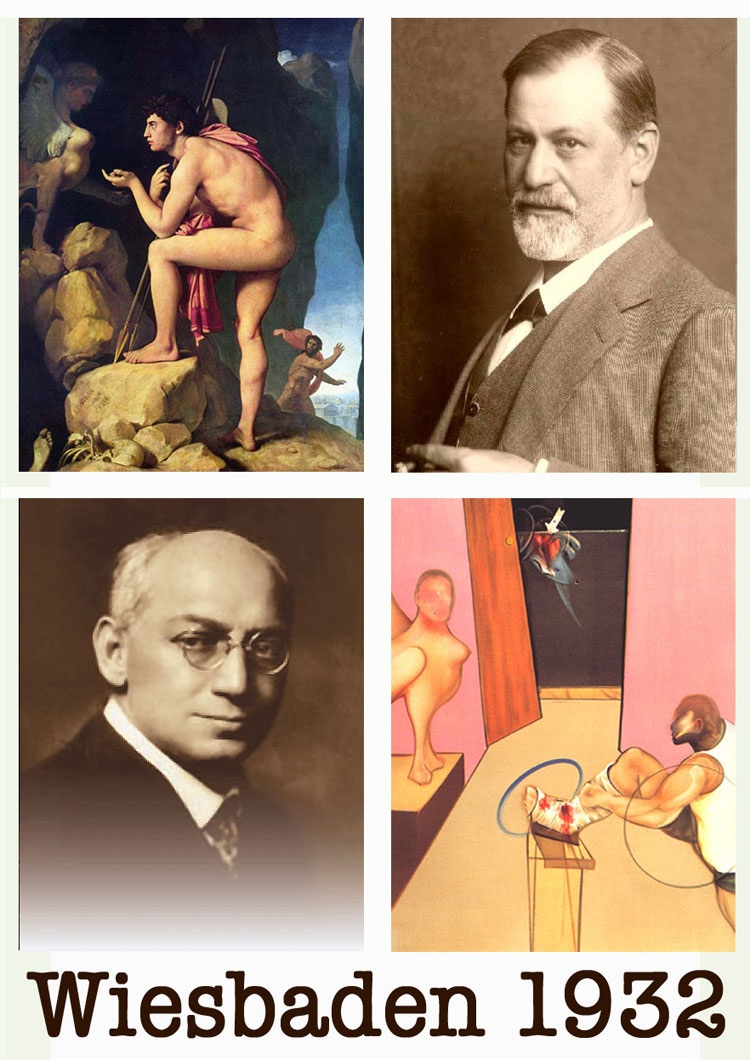L’irrequietezza di Chiara (vedere post: Turbolenze) sta un po’ diminuendo: i primi mesi di analisi sono stati contrassegnati da un continuo andirivieni dal lettino alla seggiola, posizione sdraiata, posizione seduta, in piedi, nuovamente sdraiata.
Per dirmi le cose più importanti aveva bisogno di guardarmi fisso negli occhi: forse aveva paura che la mia mente potesse spostarsi, o fuggire altrove, non per timore di un'“attenzione fluttuante” a lei sconosciuta, ma piuttosto per l’angoscia di perdere il contatto.
Fino a poco tempo fa, Chiara si voltava spesso a guardare l’orologio appeso al muro, angosciata dal passare del tempo e da qualcosa che sembra sempre sul punto di fuggire via. Poi ha imparato a girarsi una sola volta, a pochi secondi dalla fine, con sorprendente precisione. Da poche sedute ha smesso di farlo: ora il corpo è quasi del tutto quietato, ma la mente lo è molto meno.
Spesso Chiara appare sofferente e impaurita: nessuno di noi due conosce la causa di questa paura. In questi casi, mi annuncia la fine imminente dell’analisi "che non dà alcun risultato": nessun miglioramento in questi primi sei mesi di analisi, anzi: le sembra di stare peggio. E se non è migliorata in sei mesi, quanto bisognerà aspettare? Non penserò mica di “farla venire” ancora per anni? E poi, siamo proprio certi che questo metodo funzioni? O forse è lei a non essere adatta? mi ripete. “Quando le racconto un sogno -mi dice- lei è bravissimo a rigirarselo come se io le avessi parlato di lei, di noi due, della seduta. Ma che m'importa di ciò che accade qui? io devo imparare a funzionare fuori, nella vita, non quando sono qui dentro”.
La tentazione sarebbe quella di chiederle che cos’è che non va fuori di qui, ma non voglio farlo, perché sono certo che la domanda suonerebbe come una mia fuga dall’interrogativo che l’angoscia: qualcosa che la farebbe sentire in preda a una solitudine innominabile e perciò persecutoria.
“Voi psicoanalisti siete tutti uguali! Usate sempre la tecnica di rispondere alle domande con un’altra domanda”: ogni volta che Chiara mi ripete queste parole, oltre al sorriso che mi strappa l’idea di appartenere a una moltitudine di cloni, mi chiedo sempre se il problema dell’elusione della risposta, di una realtà che sfugge come un’anguilla dalla presa di una bambina disperata, non sia stato il suo problema più angoscioso. Chi sarà stato l’oggetto della caccia: la madre in fuga? E' probabile: ma è inutile arrischiarsi con interpretazioni di maniera. Chiara pretende un prodotto originale e fresco di giornata, e ne ha tutto il diritto.
Prima di avere il tempo di spiegare a me stesso tutto ciò, all’ennesima contestazione metodologica rispondo di getto: “e se fosse un paradigma?”. Inaspettatamente, Chiara sembra tranquillizzarsi: forse perché sono "sceso" sul suo piano, tentando di fare le mie ragioni. Non so nemmeno se abbia capito che, dietro questa formula un po’ astrusa, intendo dirle che interpretare un sogno come se fosse la rappresentazione dell'interazione che c’è fra noi potrebbe non essere un’idea tanto "inutile", perché attraverso il sogno si può forse cogliere qualche funzionamento di base, qualche paradigma di relazione, adatto a fornire senso tanto a quello che accade in seduta, quanto a ciò che capita nella vita di tutti i giorni. Interrogandomi sulla ragione di quella calma improvvisa, mi dico che può darsi persino che Chiara si senta tranquillizzata semplicemente perché sto seguendo il filo logico dei suoi discorsi, anziché spostarmi su un altro piano, che almeno a me potrebbe sembrare più denso di significato.
Chiara è sempre abitata da un “qualcuno interno” che disapprova fortemente il suo venire in analisi; qualcuno che mi dà continui “penultimatum”: forse fra qualche mese "non verrà più". Forse in occasione della mia prossima assenza di una settimana, “si prenderà una pausa di riflessione”.
A volte fa il conto di ciò che ha guadagnato e speso durante quella specifica seduta, come un ragioniere alle prese con la partita doppia: ha rinunciato a fare qualcosa per venire qui, e quello che le ho detto non le è servito a niente. Chiara si diletta di lavori di bricolage edilizio, e approfittando di questo suo hobby le dico: “quello che facciamo qui assomiglia, più che al lavoro edile, al lavoro agricolo. Il piastrellista sa esattamente quante mattonelle servono e quante può posarne in un giorno, mentre l’agricoltore sa che l’albero cresce senza particolare fretta, senza scadenze programmate. Mi dispiace che questa prospettiva la spaventi, ma non conosco alternative.”
Istintivamente, le requisitorie di Chiara mi spingerebbero a tacere: ci ho messo un po’ a capirlo, ma poi sono giunto a concludere che quel mio silenzio, ammantato di tolleranza apparente, è in realtà un modo per arginare una sottile irritazione, leggera e sottotraccia, che mi fa appassire la fantasia.
Nella stanza di analisi, siamo minacciati dalla routine che ci fa sembrare scontati i nostri stati d'animo, che invece non lo sono per niente; e i pazienti se ne accorgono. Matilde, per esempio, è diventata bravissima nel cogliere le mie reazioni emotive ai suoi comportamenti. Ogni tanto mi dice: “lei si è appena arrabbiato”. Gli antichi maestri ci avevano insegnato che quando il paziente tenta di fornire interpretazioni all'analista, allora significa che è maniacale, che non tollera la dipendenza, che vuole invertire i ruoli. Ma in un paio di occasioni, ho dovuto riconoscere che Matilde aveva individuato la mia irritazione prima di me. Non c’ero arrivato da solo, nonostante quella mia reazione non fosse poi così imprevedibile: Matilde è bravissima anche nel farmi arrabbiare.
Le occasioni in cui provo rabbia sono in genere quelle in cui il piacere di stare in contatto emotivo con la persona che ho davanti mi viene sottratto: capita con Matilde quando rimane ostinatamente arrotolata dentro il suo carapace, e capita con Chiara, in maniera più sottile, quando mi sento lontano dalla possibilità di fantasticare e di interpretare, dovendomi occupare di qualcosa che assomiglia a una lite di condominio.
Con Chiara ogni interpretazione di contenuto è prematura: lei non può ancora affidarsi, né fare a meno di esaminare al microscopio ogni cibo che le viene offerto, pretendendo di sezionarlo e soppesarlo in ogni sua molecola. Per questo occorre, preliminarmente, riuscire a mostrarle che può fidarsi di qualcuno; che a qualcun altro può essere delegato il compito di vigilare sulla qualità dei cibi, che riposarsi è necessario e possibile, se qualcun altro fa la guardia. Quando ci riesco -spero di imparare- si sente arrivare una specie di calma, come una pioggia insistente e prolungata che all’improvviso smette.