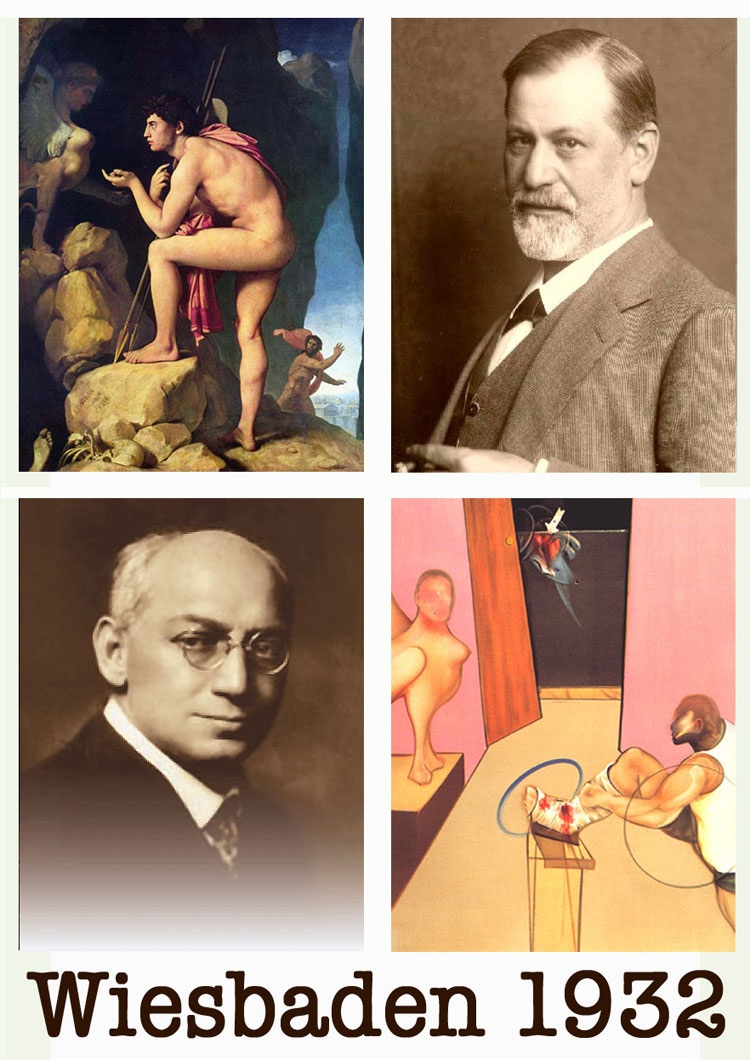"Ci sono due modi di affrontare la morte, diceva Schopenhauer: il modo della ragione e il modo dell’illusione e della religione, con la sua speranza della persistenza della consapevolezza e di un’accogliente vita dopo la morte. Per cui il fatto e la paura della morte sono il progenitore del pensiero profondo e la madre tanto della filosofia che della religione” (Irvin Yalom, La Cura Schopenhauer, Neri Pozza editore, pag. 451).
Qualche giorno fa Matilde, avendo notato che il libro era sul mio tavolo da un po' di tempo, mi ha chiesto se non lo avessi ancora terminato. “Non ancora", ho risposto. "Dal momento che alla fine del romanzo lo psicoanalista muore, voglio leggerlo lentamente".
Poche pagine più avanti, in un momento in cui ero particolarmente immerso nella lettura, mi sono imbattuto in un passaggio che sembrava fare da specchio ai miei pensieri: “Vedere la fine ci porta sempre a rallentare il passo. I lettori sfrecciano rapidamente attraverso le mille pagine dei Fratelli Karamazov fino a quando non ne rimangono che una dozzina, e allora all’improvviso diminuiscono la velocità di lettura, assaporando ogni paragrafo lentamente, succhiando il nettare da ciascuna frase, da ciascuna parola” (ibid., pag. 375).
Ma c’era di più. Per tutto il tempo della lettura avevo accarezzato la speranza, neppure troppo inconsapevole, di un happy end: alla fine Julius, lo psicoanalista ammalato di una grave forma di cancro, non sarebbe morto. E magari sarebbe stata proprio una magia psicoanalitica a guarirlo silenziosamente. In fondo -mi sono ripetuto spesso- se si sospetta che il cancro possa essere scatenato da ragioni emotive, potrebbe anche accadere che la soluzione di conflitti lo guarisca. Ma anche se non ho mai dato molto credito a questa fantasia, di tanto in tanto essa si ripresenta.
In ogni modo, pochi giorni prima dell’ultima seduta prevista e dello scioglimento definitivo del gruppo, Julius improvvisamente si aggrava e muore. Il lavoro terapeutico è concluso, i suoi membri sono cambiati in misura fino a poco tempo prima imprevedibile, e persino l’analista, poco prima di morire, mette a fuoco la propria trasformazione: è cambiato anche lui, come è giusto che accada in ogni analisi ben riuscita. Pochi anni prima, un suo paziente gravemente ammalato che egli aveva curato fino alla fine, negli ultimi istanti gli aveva detto: “grazie per avermi salvato la vita”. Leggere quella frase mi ha colpito: penso a quante volte usiamo l'espressione "salvare la vita" come sinonimo dell'allontanare la morte. Ma una vita salvata è molto di più: in alcuni casi, addirittura, il problema è quello di salvare vite già vissute, fornendo loro, anche retrospettivamente, un senso.
Invece noi ci preoccupiamo soltanto di scansare la morte, come se il lutto anticipato per la scomparsa della coscienza fosse tutto e soltanto ciò che importa. Qualcuno ha scritto che la prospettiva della gioventù è quella di un futuro che si perde a vista d'occhio, mentre nella vecchiaia il tempo trascorso ci sembra sempre incredibilmente breve: la durata, ecco ciò che ci preoccupa maggiormente. La durata a scapito della qualità.
Così, con la vita salvata dalla psicoterapia vissuta dalla parte di chi cura, Julius muore. Mentre ancora sto indugiando con gli occhi sulle scene finali del romanzo, anche il mio ostinato desiderio che la morte si allontani mi appare tutt'a un tratto estraneo e bizzarro, e la fine un fatto assolutamente normale e persino necessario, come l'ultima pagina d'un libro. Mi vedo seduto in un cinema, mentre assisto alla scena finale di un film che mi ha coinvolto moltissimo, e perciò decido di non alzarmi, voglio che ci sia un terzo e un quarto e un quinto tempo. Ma no invece: d'un tratto tutto questo mi appare spiacevole, noioso, addirittura soffocante: io devo -anzi voglio- alzarmi e andar via. Il film mi ha saziato e insistere ulteriormente sarebbe un'insensata e tormentosa bulimia. E' ora di uscire.