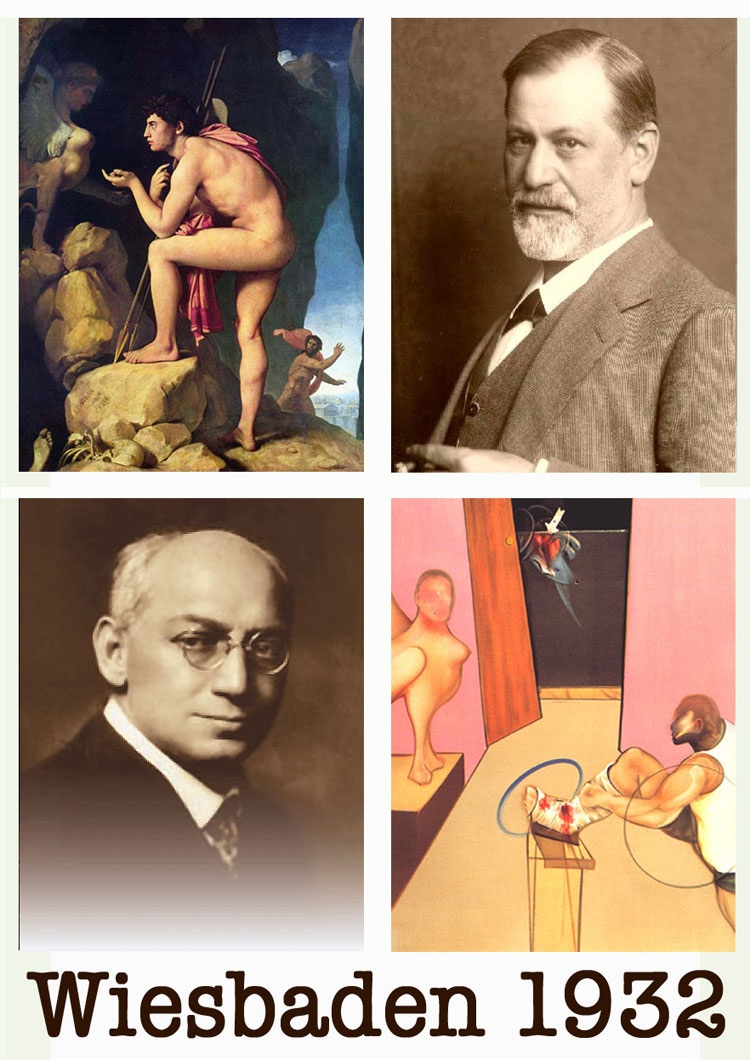Per
Jamila, ragazza scampata a un padre sadico, a una religione che non rispetta le donne, agli scafisti, alla furia del mare, credo di essere un «objet trouvé» o un accidente: qualcosa (una cosa?)
che si incontra per caso, camminando in uno spazio sterminato perché
privo di confini, di strade e di senso, e nella disperata speranza che il
lancio dei dadi che costituisce per lei l’unica opzione esistenziale abbia come
risultato un doppio sei, al di fuori del quale sembra esserci il nulla, un
vuoto che potrebbe essere riempito soltanto da nuove persecuzioni.
Questa
riflessione mi sale alla mente subito dopo la chiusura di una seduta durante la
quale il contatto ha fluttuato a lungo nell’aria: Jamila è arrivata in ritardo,
e quando sono andato a chiamarla, telefonava. Ha continuato per un po’ a
parlare al telefono mentre mi seguiva lungo il corridoio, e ha smesso
all’improvviso rivolgendomi un sorriso carico di malinconia, nel momento in cui
ha attraversato la porta. Subito dopo, mentre ci stavamo sedendo, ha iniziato a
cantare. Canta spesso Jamila, anzi “sempre” come proclama con finto orgoglio; e
il suo canto ha il rumore dell’ansia, della paura a stento mantenuta sotto
traccia.
Parliamo
dei suoi contatti. Che non sa mantenere, che teme di perdere, che a volte
sembrano sfuggirle sotto i colpi della sua stessa spietatezza. Eppure Jamila è
buona: il suo senso di giustizia è cresciuto nella desolazione desertica della
violenza e dell’assenza di affetti. E questo la costringe a sentirsi a volte
troppo permeabile e a volte inutilmente spietata.
Mentre
Jamila parla, ho spesso la sensazione di perderla. E questa sensazione, oggi,
si è presentata in forma di sonno, violento e apparentemente immotivato.
Il
sonno mi mette a disagio: sono forse disinteressato a lei, troppo tiepido verso
i suoi affetti disperati, anch’io da mettere nel novero di quanti le hanno
girato le spalle?
"Lo
sa che l’ho appena persa?" Le chiedo. "Mi capita sempre, risponde, io
rifiuto le persone". Anche quelle di cui sente di avere un disperato
bisogno? Mi chiedo. Ma non aggiungo altro: credo che nessuno dei due, ameno per
il momento, sarebbe in grado di rispondere con certezza.
La
seduta si avvia alla fine. Ci rivedremo fra sette giorni, sempre alla stessa
ora. "Alle tre e mezza?" Mi chiede Jamila. "No, alle tre, come
sempre". Oggi è arrivata con un po’ di ritardo credendo di essere in
anticipo. Spesso Jamila mi telefona il giorno prima: è domani la seduta? E’
alle tre e un quarto? Sembra che nella sua agenda, un appuntamento che aspira a
radicarsi, faccia ancora troppa paura.